Ottantuno
tombini in Vico Santa Lucia?
Facciamo le
persone serie per cortesia!!

Che pena osservare nel centro storico
murato di Gela quelle sue parti stravolte
dall’esecuzione di un progetto, pagato a fior di
milioni dal demanio, che ha creato un contesto
alieno di arredo urbano; zone in particolare
riferite al Corso, che va da Piazza Calvario a
Via Marconi, alla piazza Sant’Agostino e al vico
Santa Lucia. Forse abbiamo a che fare con un
manufatto che dovrebbe essere inserito nei libri
di storia dell’arte quale esempio di “…grande
opera architettonica”. Ironia a parte, ci si
chiede: …e quelli che avrebbero dovuto
controllare, quali giustificazioni potranno
dare, ammesso che li diano o che se ne siano
accorti?
Se si passa nel dettaglio del Corso e
dell’ex vico Santa Lucia poi si cade veramente
nel grottesco; infatti, sulla parte del Corso
tra via Marconi e via Porta Vittoria, a parte un
basolato stradale molto rilevato che rende
difficoltoso alle donne con i tacchi camminarci,
sono stati inseriti sul marciapiede di 2,5
metri, già quindi di limitate dimensioni, dei
blocchi rettangolari di 75 cm. su cui sono stati
posti dei pali con un’illuminazione di tipo
fioca quasi cimiteriale a parte il filo della
presa di terra volutamente scoperto, mentre
sulla strada e sugli stessi marciapiedi sono
stati realizzati qualcosa come 180 tombini di
varie dimensioni (marciapiede lato sud n. 76
tombini, strada del Corso n. 31, marciapiede
lato nord n.73). Per vico Santa Lucia ci si
chiede come è concepibile che in circa 500 metri
quadri di superficie si siano potuti ricavare
qualcosa come 81 tombini di diverse dimensioni e
peggio ancora senza averli opportunamente
occultati! Incredibile ma vero, il lettore si
passi il piacere perverso di andarli a contare.
Eppoi che cosa c’entrava la realizzazione
di questa specie di due abbeveratoi quando in
questo vicolo e in via De Sanctis l’unica
struttura esistente in antico erano delle
fontanine? E’ vero che i nostri conterranei
progenitori realizzarono gli abbeveratoi, ma
sempre ubicati al di fuori del centro storico,
come ad esempio quelli di contrada Carrubbazza
e l’altro di fronte all’ingresso del Cimitero
monumentale, da decenni non più esistenti perché
ignorantemente demoliti da diverse
amministrazioni comunali.
Si è fatto in particolare un calcolo di
probabilità sul numero dei tombini relativo alla
definizione dei lavori previsti dal progetto in
questione, in particolare negli 800 metri che
vanno da Piazza Calvario all’incrocio della zona
dei Quattro Canti. Si è arrivati ai seguenti
dati: Vico Santa Lucia con 81 tombini (già
esistenti), Corso da piazza Calvario a via
Marconi (m. 258) con un totale di 180 tombini
(già esistenti); da via Marconi ai Quattro Canti
(m. 547) con 381 tombini; via Giacomo Navarra
Bresmes (m. 318) con 220 tombini; Piazza S.
Agostino e via De Sanctis con 90 tombini (giù
esistenti). Così in base alla somma di tali
numeri si arriverebbe ad un totale di quasi
mille tombini (81+180+381+221+90 = 953)!! Un
immenso tombinaio nel centro storico murato di
Gela. Alla faccia…
E’ condivisibile intanto l’azione di
ironica provocazione del Cav. Carlo Varchi, il
quale tempo addietro portò un quadrupede in Vico
Santa Lucia per farlo abbeverare in questa
specie di abbeveratoio, da cui peraltro non è
mai uscita una goccia d’acqua.
.jpg)
Ed ancora. A quale dettame architettonico
di arredo urbano si è rifatto il progettista
andando a realizzare una superficie basolata a
macchia di leopardo del vico Santa Lucia e dei
marciapiedi del corso e di Piazza Sant’Agostino,
con piccoli basoli peraltro cementati con
materiale che, forse col tempo e con l’azione
erosiva dell’acqua piovana, creerà tanti di
quegli avvallamenti da rendere difficoltoso
camminarci sopra. A proposito di queste
basolette si vuole ricordare che tempo fa
intervenne anche il compianto Avv. Vincenzo
Capici che peraltro contestò al progettista la
scivolosità di tali mattonelle durante la
pioggia per le persone costrette ad utilizzavano
il bastone per camminare. Ed ancora, che senso
ha avuto andare ad impiantare sul lato sud del
vico prospiciente il Corso dei blocchi
cilindrici di pietra sbilenchi che,
contrariamente all’estetica che si rispetti,
danno solamente un effetto di cattivo gusto;
senza contare quelli in Piazza Sant’Agostino e
davanti la banca Intesa sul Corso, definiti come
tabuti (ovvero casse da morto) dalle persone;
per non scrivere del “belvedere” di via De
Sanctis, prospiciente via Porta Vittoria, da cui
affacciandosi c’è poco di bello da vedere!
Sarebbe stato corretto definirlo “malvedere”!! E
delle due scale ai lati del “malvedere”, che
dire? In una di esse, definita dallo scrivente
“la scala dello scippo”, diverse signore di
sera, uscite dalla vicina chiesa di
Sant’Agostino dopo la messa, hanno subito delle
rapine tant’è che per evitare il ripetersi di
tale incresciosa situazione preferiscono tuttora
di fare il giro più lungo passando dal Corso per
ritornare a casa.
Quella dei basolati purtroppo è stata da
sempre una iattura di tutte le amministrazioni
comunali che dagli anni Sessanta in poi si sono
susseguite alla guida di Gela; sono senza fine i
danni causati ad una delle più importanti
componenti architettoniche di una città, danni
imputabili spesso a ignoranti capricci, peggio
forse ad interessi personali. Che orrore
constatare che del basolato antico di pietra
della lava del Vesuvio e dell’Etna a Gela non
sia rimasto più nulla se non qualche tratto di
Via Navarra, di Via Rossini e di Via Marconi,
peraltro quest’ultimo tutto squinternato e mal “ripizzatu”
di asfalto. E che dire delle grosse basole di
pietra bianca comisana dei marciapiedi del Corso
da Molino a Vento al Cimitero, 4 chilometri in
totale, eliminati durante i lavori dei “cantieri
scuola” nel 1987?! La cosa più importante, però,
è quella di capire che fine hanno fatto tali
basole divelte. Ci si chiede se sono state
rivendute, oppure sono state lasciate alla mercè
del primo che passava. Cosa probabile
quest’ultima se non certa dal momento che in
diverse ville, tali grosse basole fanno bella
mostra di sè.

Che strana scelta
progettuale poi è quella che a Gela si tende ad
“occupare” a tutti i costi le superfici libere
(nate come tali) del centro storico peraltro
facendo spendere di più con l’impianto di
fontane, piscine, fosse, alberi a grande chioma
e quant’altro snaturandone di conseguenza il
contesto originario, tipo Vico San Rocco, Via
Giacomo Navarra Bresmes, Piazza Vittorio Veneto,
Piazza Sant’Agostino, piazzetta contigua alle
Scuole Santa Maria di Gesù in Via Ventura e
Piazza San Giacomo dove peraltro è stato creato
un falso storico con l’impianto del portale
trecentesco della vicina chiesa di San Giacomo.
Che senso ha parlare ancora di centro storico
quando di storico non rimane più quasi nulla?
Ci si chiede che fine faranno di questo
passo il Corso e le rimanenti piazze del centro
storico murato di Gela inseriti nel contesto del
progetto di “Una via e tre piazze”; come ad
esempio Piazza San Francesco dove si prevede una
cavea quadrata per assistere …agli spettacoli.
Su questa piazza, però, non è detta l’ultima
parola in quanto esistono diverse perplessità
che potrebbero essere incompatibili con i lavori
previsti, infatti tale piazza non era compresa
nel progetto originario, quindi probabilmente di
motu
proprio è stata scelta per sostituirla a
Piazza Roma senza le dovute azioni che ne
precedono la fattibilità. C omunque si starà a
vedere.
Certamente non ci sembra un’idea
peregrina quella di realizzare i progetti che
interessano la collettività tenendo conto anche
dei pareri, se pur non vincolanti, di specifiche
associazioni e di quelli dei comitati di
quartiere; un caso di antesignana visione sul
coinvolgimento della gente nella realizzazione
delle opere pubbliche. Forse il caso di Piazza
Roma, che è stato escluso dal progetto di cui
sopra, ha rappresentato un’eccezione grazie
soprattutto agli abitanti di tale quartiere ma
anche all’intervento efficace di Saro Crocetta
(esiste un filmato che attesta tale scelta) che
si dimostrò un antesignano contestatore dello
progetto anche se lo stesso politico, però,
cambiando clamorosamente idea dopo l’elezione a
sindaco (del 12 marzo 2003), contribuì a
portarlo in esecuzione.
Non si scrive nulla di eccezionale
nell’affermare che il cortile di Santa Lucia
(una volta cortile, oggi una via), le vie e le
piazze di Gela tutte non sono di proprietà degli
amministratori, né degli architetti, né della
gente che ci abita, ma sono di tutti.
E per quanto riguarda gli ottantuno
tombini in Vico Santa Lucia?
Facciamo le persone serie per cortesia!!
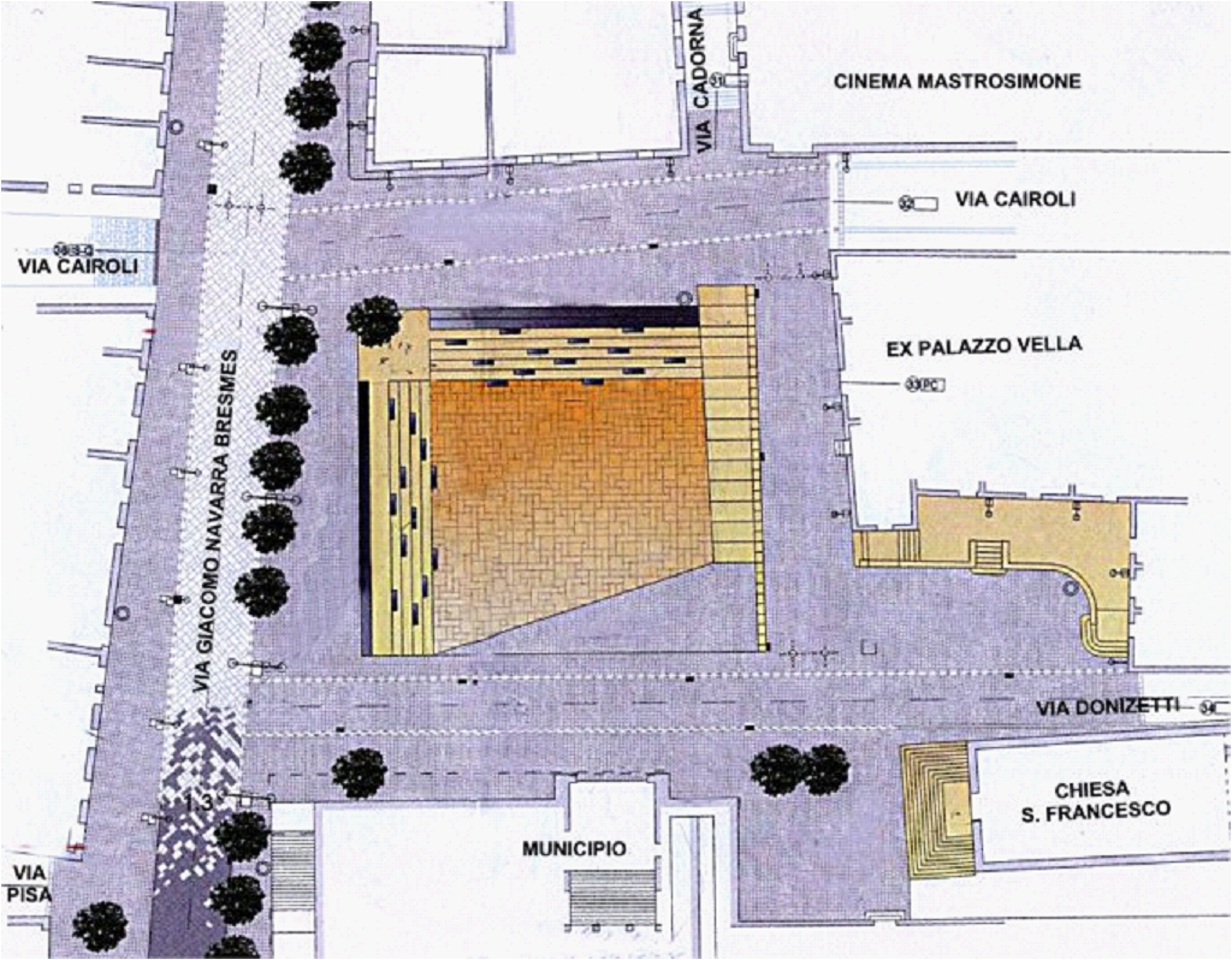
ARENE CINEMATOGRAFICHE A GELA

La cartolina di oggi, risalente agli anni Sessanta, si riferisce ad una veduta del Municipio con una foto scattata da una casa prospiciente via Carducci nel quartiere Ospizio Marino. Di cartoline che ritraggono l’attuale Municipio ne esistono molte, ma questa in particolare richiama l’attenzione perché oltre al Municipio si vede una zona riferita all’orto di Don Nino Sola, una volta coperto di verde e oggi intensamente fabbricato, con un’arena cinematografica, l’arena Aurora, oggi ridotta di superficie e con quel che rimane da decenni in fase di abbandono. Fino a più di mezzo secolo fa i cinematografi di Gela, prima della realizzazione di aperture del loro tetto (come i cine-teatro Royal, Ariston e Mastrosimone), in estate rimanevano chiuse perché erano sostituite dalle arene cinematografiche. A Gela esistevano fino alla seconda metà degli anni Cinquanta ben sette arene, funzionanti durante il periodo estivo di cui riportiamo un elenco in ordine temporale: ARENA GARIBALDI all’interno della villa comunale, ARENA LITTORIO nel quartiere Orto Fontanelle sotto il Municipio (durante lo Sbarco Alleato quest’arena fu trasformata in campo di raccolta dei prigionieri italiani), arena DEL SOLE nel quartiere Molino a Vento dove ora sorge il Museo Archeologico, ARENA TRINACRIA O MIRAMARE sotto il Bastione nel quartiere Rabatello, ARENA STELLA DEL MARE, nel quartiere Toselli, dove sulla sua superficie diversi lustri fa è stato ricavato un parcheggio (denominato appunto Parcheggio Arena), ARENA AURORA in Via G. Carducci (quella che si vede sulla cartolina presentata oggi) e l’ARENA GARDEN al Villaggio Aldisio in Via Disueri di cui oggi rimangono ancora i muri perimetrali.
.jpg)
In ognuna di tali arene cinematografiche i posti a sedere erano spesso separati da una transenna; quelli vicini allo schermo, dove si pagava di meno, e gli altri vicini alla cabina di proiezione del film. I filari dei sedili erano in ferro e prima dell’ingresso all’arena, al prezzo di L. 5, erano forniti agli spettatori dei cuscini che evitavano il bagnarsi dei pantaloni con l’umidità che si depositava sulla superficie degli stessi sedili; poi a fine film erano spesso buttati in aria dagli spettatori e conseguentemente recuperati dalla cosiddetta maschera, che li rimetteva di nuovo in circolo. Nel caso di una casuale pioggia i biglietti potevano essere usati per altre giornate.


Nell’arena Stella del Mare gli spettatori durante la proiezione a volte erano colpiti da pietre, lanciate sconsideratamente da ragazzini da via Istria, proprio a ridosso dell’arena cinematografica, senza che mai si riuscisse a prendere i colpevoli o a limitarne la loro deplorevole azione. Le ultime arene cinematografiche, che si sappia, funzionanti fino agli Sessanta furono l’Arena Stella del Mare e l’Arena Garden; poi sparirono anch’esse definitivamente chiudendo così, senza più riaprirlo, il ciclo storico dell’intrattenimento estivo delle arene cinematografiche di Gela; anche se dal 2011 al 2015 nel quartiere Macchitella lo spazio antistante al Cine Teatro Antidoto fu trasformato in arena cinematografica. Oggi la proiezione di film avviene solamente nella multisala Hollywood, l’unica a tale scopo che è rimasta a Gela.
.jpg)
La
cartolina, che ritrae anche parte dell’arena
cinematografica Aurora, con ingresso in via
Carducci, a ridosso dell’ex orto di Don Nino
Sola sotto viale Mediterraneo, riporta sul retro
le scritte The City Hall - Hotel de Ville
Stadthaus e Ed. Cartolibreria G. B.
Randazzo - Gela - Vera
Fotografia. S. A. Fototipia Berretta - Terni.
LA TRAGEDIA DELLE FOIBE

E’
da qualche decennio che la storiografia
italiana sta mettendo in luce il tragico evento
delle foibe (cavità
naturali presenti sull’altipiano alle spalle di
Trieste e dell’Istria) dove
i titini, ovvero i partigiani di Tito, vi
gettarono migliaia di persone, alcune dopo
averle fucilate, altre ancora vive; tutte
colpevoli di essere italiane o contrarie al
regime comunista.
Avvenimenti purtroppo sotto certi aspetti ancora
poco chiari nella piena contezza della storia
contemporanea.
Nel 2005 il
Parlamento italiano ha scelto il 10 febbraio
come giornata del ricordo per commemorare
l’olocausto degli Italiani dell’Istria e della
Dalmazia, anche se spesso è stato
considerato
solamente come una conseguenza o una vendetta,
derivata da venti anni di fascismo con le
persecuzioni fasciste antislave nella regione di
confine.
Infatti, prima del
1943 in Jugoslavia, i fascisti avevano istituito
dei campi di internamento per migliaia di
jugoslavi, in particolare per i partigiani
comunisti di Tito; addirittura i fascisti
avevano fatto pubblicare il 1° dicembre del 1942
la “circolare 3C” dal Comando superiore FF.AA.
“Slovenia e Dalmazia”, firmata da Mario Roatta,
Generale del Secondo Corpo d’Armata,
con distribuzione estesa sino ai comandanti di
battaglione e reparto o enti corrispondenti;
circolare che impunemente autorizzava a
giustiziare gli ostaggi, deportare famiglie
intere e a distruggere case, fattorie e
bestiame, inoltre, nella “Parte Quinta” era
previsto il “trattamento da usare alle
popolazioni ed ai partigiani nel corso delle
operazioni” oltre al fatto che
tale trattamento non doveva essere sintetizzato
dalla formula “dente per dente” bensì da quella
“testa per dente”.
Si volle quindi regolare l'atteggiamento che le
truppe italiane dovevano mantenere nei confronti
della resistenza jugoslava e della popolazione
civile dei territori occupati, con
l’accettazione del principio di complicità della
popolazione residente in un'area di attività
partigiana e assumendo come metodo la politica
del terrore contro i civili, ordinando
rappresaglie, deportazioni, confische, catture
di ostaggi e fucilazioni sommarie. Addirittura
Benito Mussolini
nel 1920 in un comizio a
Pola affermava: “…di
fronte ad una razza inferiore e barbara come la
slava, non si deve seguire la politica che dà lo
zuccherino, ma quella del bastone. I confini
dell’Italia devono essere il Brennero, il Nevoso
e le Dinariche: io credo che si possano
sacrificare 500.000 slavi barbari a 50.000
italiani”.
Dopo la
firma dell’armistizio dell’8 settembre 1943
esplose la prima ondata di violenza dei titini;
in Istria e in Dalmazia i partigiani slavi di
Tito decisero di vendicarsi contro i fascisti e
gli italiani non comunisti. Torturarono,
massacrarono, affamarono e poi gettarono nelle
foibe circa un migliaio di persone.
Successivamente nella primavera del 1945 la
violenza aumentò, in particolare quando la
Jugoslavia occupò Trieste, Gorizia e l’Istria.
Le truppe del Maresciallo Tito si scatenarono
contro gli italiani. Ad
essere buttati dentro le foibe (infoibati) ci
furono fascisti, cattolici, liberaldemocratici,
socialisti, uomini di chiesa, donne, anziani e
bambini indistintamente.
Gli infoibati furono prevalentemente italiani, ma
in generale anche tutti coloro che si opponevano
al regime comunista di Tito
e quindi erano compresi anche sloveni e croati.
Tra gli italiani vi erano ex fascisti, ma soprattutto
gente comune colpevole solo di essere italiana o
contro il regime comunista.
Nel febbraio del
1947 l’Italia ratificò il trattato di pace che
pose fine alla Seconda
Guerra Mondiale con
l’Istria e la Dalmazia che vennero cedute alla
Jugoslavia;
così
trecentocinquantamila persone si trasformarono
in esuli scappando dal terrore che, però, non
trovarono in Italia una grande
accoglienza. Forse la sinistra italiana allora
li ignorò in quanto non suscitava solidarietà
chi stava fuggendo dalla Jugoslavia, da un paese
comunista alleato dell’URSS, in cui si era
convinti che era stato realizzato il sogno del
“socialismo reale”.Fino a tempi recentissimi il
dramma delle foibe e tutto ciò che accadde
allora, prima e dopo, non venne mai
approfondito, nonostante
che si abbia avuto a che fare con una delle
pagine più angoscianti della storia italiana, di
cui è iniziata molto più tardi l’elaborazione.
Quindi, la persecuzione
proseguì fino alla primavera del 1947, fino a
quando, cioè, fu fissato anche se in maniera non
definitiva il confine fra l’Italia e la
Jugoslavia; infatti, per avere un confine
definitivo tra i due Stati bisognò aspettare il
“Trattato di Osimo” del
10 novembre 1975, in cui si riconobbe la
sovranità jugoslava sui distretti di
Capodistria (oggi in Slovenia) e di Buie (oggi
in Croazia) e confermava quella italiana a
Trieste. “…Sembra proprio
che quel 10 novembre 1975 il confine sia stato
determinato in maniera ormai immodificabile e
che l’interesse nazionale, che avrebbe dovuto
dirigere la politica estera nella ex Jugoslavia,
sia stato considerato un orpello sovranista del
quale fare a meno
Da un’indagine del Centro
Studi Adriatici, raccolta in un albo pubblicato
nel 1989, le vittime di tale tragedia furono
10.137 di cui 994 infoibate, 326 accertate ma
non recuperate dalle profondità carsiche, 5.643
vittime presunte sulla base di segnalazioni
locali o altre fonti, 3.174 morte nei campi di
concentramento jugoslavi. Certamente rispetto
alle stragi naziste nei lager con milioni di
morti c’è una notevole differenza di numero, ma
l’orrenda morte degli infoibati è stata una
peculiarità unica nelle atrocità dell’ultima
guerra. La cosiddetta impropriamente "caccia al
fascista", si esercitò non solo sui fascisti ma
anche nei confronti di antifascisti, dei
componenti dei Comitati di Liberazione Nazionale
di Trieste e di Gorizia e degli esponenti della
Resistenza liberaldemocratica e del movimento
autonomistico di Fiume. Dunque, infoibati perché
italiani! Lo storico triestino Roberto Spazzali
sintetizza "…Le foibe furono il prodotto di odi
diversi: etnico, nazionale e ideologico. Furono
la risoluzione brutale di un tentativo
rivoluzionario di annessione territoriale. Chi
non ci stava, veniva eliminato".Il dramma delle
foibe a danno di militari e civili italiani,
dapprima nell'autunno del 1943 e successivamente
nella primavera del 1945, rappresenta tutta una
storia di tragedie, di morti e di sofferenze,
una storia vissuta oltre dai soldati, mandati
allo sbaraglio e alla morte dal regime fascista,
anche dalla popolazione civile soprattutto nelle
carceri e nei campi di concentramento iugoslavi.
Militari gelesi in
Iugoslavia
Si riportano
adesso qui di seguito i nominativi di sei
militari gelesi (di cui tre carabinieri) che
furono allora vittime della vendetta dei titini
iugoslavi:
CORFU’ PAOLO,
nato a Terranova di Sicilia il 14 aprile 1920.
Carabiniere aggregato al 2°
Rgt. Fanteria della
Milizia Difesa Territoriale, deceduto per
infoibamento l’11 giugno 1944 nella foiba di
Pisino, lunga 500 m. e profonda circa 100 metri,
a Pedena d'Istria in Croazia, un volta in
provincia di Pola.
FASULO SALVATORE
di Luigi. Nato a Terranova di Sicilia il 2 marzo
1906. M.llo dei Carabinieri in Jugoslavia
aggregato al 1° Rgt. Fanteria “Trieste”,
arrestato il 30 aprile
1945 e tradotto in un campo di internamento a
Susak, una piccola
isola del nord dell’Adriatico. Considerato
disperso, probabilmente soppresso dai titini il
31 dicembre 1945.
SPURIO GIOVANNI
di Luigi. Nato il 7 maggio 1908 ad Ascoli Piceno
e residente a Terranova di Sicilia. Carabiniere
della Guardia Nazionale Repubblicana a Zara.
Considerato disperso il 18 novembre 1944 a Vis
Isola di Lissa in Dalmazia, probabilmente
soppresso dai
titini
e sepolto in Jugoslavia;
LICATA GIOVANNI.
Nato a Terranova di Sicilia il 15 settembre
1893. Soldato sul fronte iugoslavo deceduto il
14 maggio 1943 soppresso dai
titini e sepolto in
Jugoslavia.
MINARDI BIAGIO
di Giovanni e di Tuvè Francesca.
Nato a Terranova di Sicilia il
19 giugno 1915. Deceduto il 25 giugno 1943
soppresso dai
titini e
sepolto in Jugoslavia.
MAURO EMANUELE di Giovanni. Nato a Terranova di Sicilia nel 1923. Arrestato a Monfalcone l’8 maggio 1945 e deportato nell'ospedale militare del Seminario Minore a Gorizia. E’ presente nella lista “Ritornati” di oltre 1.000 deportati e infoibati di Gorizia
Le foibe di Basovizza e
Monrupino
La “Foiba di Basovizza”, originariamente un pozzo minerario, una della cinquantina di luoghi di infoibamento, nel maggio del 1945 fu un posto di esecuzioni sommarie per prigionieri, militari, poliziotti e civili per mano dei partigiani comunisti di Tito. Durante i 40 giorni di occupazione jugoslava di Trieste, a partire dal 1° maggio 1945, centinaia di persone furono prelevate dalle loro case e portate ai campi d’internamento presenti in Slovenia anche se non tutti furono internati, al contrario di numerosi prigionieri che furono direttamente destinati a Basovizza per essere ferocemente ammazzati. Gli autocarri, noti come “autocarri della morte”, trasportavano le vittime con le mani legate da filo di ferro, prima spogliate e poi seviziate, e spesso unite tra loro in catene umane. Giunte al margine dell’abisso, furono spinte verso il bordo mentre una raffica di mitra faceva precipitare tutti nella voragine. La caduta di circa 200 metri era spesso mortale, ma chi sopravviveva al volo continuava ad agonizzare tra le ferite e le lacerazioni provocate dagli spuntoni di roccia. Dal 1992, la Foiba di Basovizza è stata ufficialmente riconosciuta come Monumento Nazionale italiano, mentre nel 1993 lo è diventato pure la foiba di Monrupino. Questi luoghi oggi mettono in rilievo la loro importanza storica di riflessione e commemorazione per ricordare le atrocità commesse durante quel tragico periodo; e diventano un luogo di pellegrinaggio per coloro che vogliono onorare le vittime delle violenze e mantenere viva la memoria di questi passati eventi drammatici.
Giorno del Ricordo
Il Parlamento Italiano, con legge 30 marzo 2004
n.92, istituì il
Giorno del Ricordo,
in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo
giuliano-dalmata,
e delle vicende del confine orientale,
prevedendo la concessione di un riconoscimento
ai congiunti degli infoibati, al fine di dare un
segnale di risarcimento morale ai pregiudizi
subiti immediatamente dopo la Seconda Guerra
Mondiale da quella parte degli italiani che
risiedevano nell'Istria, a Fiume e nella
Dalmazia.
Il riconoscimento, a titolo onorifico e senza
assegni, consiste in un'insegna metallica, con
relativo diploma, da concedere a domanda al
coniuge superstite, ai figli, ai nipoti ovvero,
in mancanza di questi, ai congiunti fino al
sesto grado, di coloro che dall' 8 settembre
1943 al 10 febbraio 1947, in Istria, in Dalmazia
o nelle province dell'attuale confine orientale,
furono soppressi e infoibati, nonché agli
scomparsi ed a quanti nello stesso periodo e
nelle stesse zone, furono soppressi mediante
annegamento, fucilazione, massacro, attentato,
in qualsiasi modo perpetrati.
