22 - Personaggi della storia di Gela
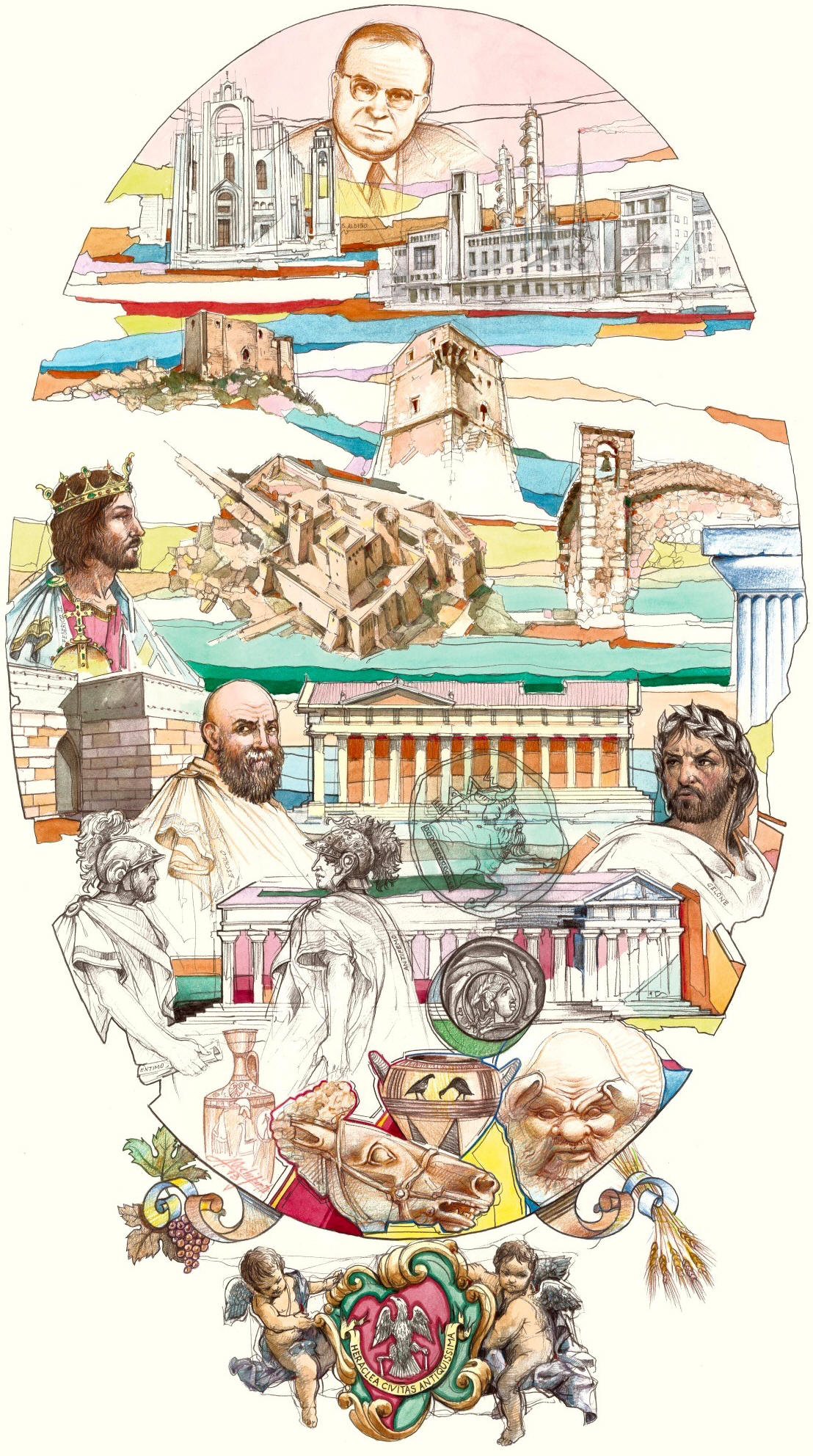
Con questo ovale,
il compianto maestro Occhipinti terminò il
percorso storico-figurativo di Gela e del suo
territorio; percorso che vide i maggiori
personaggi e gli eventi più rappresentativi
della storia millenaria di Gela.
Utilizzando sempre
la sua sensibilità coloristica, a volte
stemperata da una dettagliata modulazione delle
velature e delle trasparenze, il pittore
acquarellista raffigurò, in alto al centro, il
busto di Salvatore Aldisio che sovrasta due
opere edilizie del suo tempo: la Chiesa di San
Giacomo e il Municipio, dietro il quale, fece
trasparire alcuni impianti e la torcia del
petrolchimico come a voler coinvolgere
l’autorevole politico gelese alla svolta
economica industriale della città negli anni
Sessanta.
Si passa alla
raffigurazione di Federico II, della chiesetta
di San Biagio, preesistente all’imperatore, del
“castrum”,
del “Castelluccio” (ambedue di epoca
federiciana) e della Torre di Manfria, edificata
in epoca successiva.
Si va poi indietro
nel tempo, arrivando fino all’epoca greca con la
raffigurazione di Eschilo, di Gelone e degli
ecisti Antìfemo e Entìmo, fondatori di Gela nel
688 a.C. A essi seguono le figure delle
fortificazioni di Capo Soprano, dei templi greci
dell’acropoli, di alcuni prodotti della
coroplastica geloa e di due monete, una di Gela
e l’altra di Siracusa.
L’esterno
dell’ovale è completato con la raffigurazione di
un grappolo d’uva da una parte e un mazzo di
spighe dall’altra, due classici prodotti
dell’economia agricola di Gela. Infine, due
putti sostengono un elemento decorativo con
l’emblema della città con la scritta
HERACLEA
CIVITAS ANTIQUISSIMA, l’antica e primigenia
denominazione medievale di Gela.
Lo scrivente, con
questo articolo su Distretto Gelese, chiude il
percorso artistico dei 22 acquerelli sulla
storia di Gela del compianto Antonio Occhipinti
con un doveroso tributo iniziato nel dicembre
del 2023 con la presentazione al lettore degli
acquerelli che si trovano esposti nella
pinacoteca comunale. Come si osserva nella foto,
scattata durante l’inaugurazione della
pinacoteca con i 22 acquerelli del maestro il 16
aprile del 2015, a partire da sinistra compaiono
il Sindaco Avv. Angelo Fasulo, l’assessore Avv.
Giovanna Cassarà, lo scrivente, la Prof.ssa
Angela Rinzivillo, Antonio Granvillano, la
Prof.ssa Salvina Fiorilla e l’Ing. Angelo
Castronovo.

La scomparsa del Maestro Antonio Occhipinti
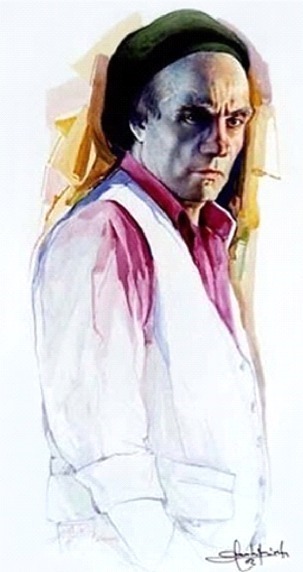
E così il 17 luglio
del 2024 il “Viaggio nel Sole” (titolo di un
depliant del 1988 di una mostra a Fregene) del
caro amico pittore acquerellista Antonio
Occhipinti si è concluso; senza il minimo dubbio
e senza nessuna enfasi il gelese Occhipinti è
stato uno degli acquerellisti più raffinati
d’Italia in quanto ha saputo sublimare la
difficile tecnica dell’acquerello.
Pietro Annigoni,
artista tra i maggiori dell’Italia di metà
Novecento, appartenente al gruppo dei “pittori
moderni della realtà” e una delle figure più
prestigiose e qualificate dell’Arte
contemporanea, così scriveva: “…Serbo un gradito
ricordo dell’incontro con il pittore Antonio
Occhipinti, un ricordo che d’altronde si
materializza nel bel ritratto che mi ha fatto e
del quale generosamente ha voluto farmi omaggio,
aggiungendoci il bellissimo acquerello di Gela.
Guardando queste sue opere, a mio agio, noto che
alle trasparenze atmosferiche vibranti di luce
sa unire una rara solidità e, specie nel
ritratto una corposità tanto difficilmente
ottenibile in questa tecnica. Credo di poter
dire con tutta tranquillità che Occhipinti è uno
dei migliori acquerellisti d’Italia”.
Non solo
acquerellista, il Maestro Antonio Occhipinti ha
diversificato il suo impegno artistico con
personalità e grande capacità offrendosi con una
vena creativa e con felici intuizioni alle
realizzazioni di armoniosa bellezza di oli,
pastelli, disegni e china a cui ha alternato con
successo scultura e incisioni.
Prese parte a
diverse mostre a carattere nazionale ed
internazionale; sue opere si trovano in
collezioni pubbliche e private. Ha ottenuto
numerosi premi e segnalazioni; critica e stampa
si sono sempre interessati di lui. Organizzò con
il Comune di Gela ed altri enti mostre
collettive ed estemporanee, ospitando a Gela
artisti affermati in campo nazionale ed
internazionale. Raffinato ed elegante,
l’acquerello di Occhipinti raccoglie la
sensibilità coloristica del Sud stemperata da
un’accorta modulazione delle velature e delle
trasparenze. La sua problematica stilistica si è
avvalsa di un nuovo slancio estetico:
raccogliere il timbro intransigente della
luminosità mediterranea per addolcirla in
contenuti di toni dall’accento espressivo ed
altamente suggestivo e piacevole. Di lui hanno
scritto Pietro Annigoni, Ignazio Buttitta, Mario
Gori, Aldo Riso, Aldo Raimondi, Antonino De
Bono, Albano Rossi, Giorgio Falossi, Luigi
Tallarico e tanti altri.
Luca Zingaretti
scriveva: “Poche parole perché scrivere di arte
non è il mio mestiere. Poche parole per
descrivere lo stupore di un profano nello
scoprire l’universo che il maestro Occhipinti
nasconde e rivela dietro i suoi acquerelli. Ho
conosciuto l’arte del maestro in occasione di
una mostra. Quello che mi colpì immediatamente
fu la luce. La luce di una Sicilia
dell’immaginario e, nello stesso tempo, del
reale. La luce dei ritratti che restituisce, a
chi guarda, l’anima che quei volti ha abitato.
Quella dei paesaggi toscani e delle marine. Nei
suoi acquerelli vive qualcosa di estremamente
vitale. Amo i suoi nudi di donna che fanno
venire in mente un’idea di sensualità placida,
leggera. I suoi vicoli deserti e assolati dietro
cui si intuisce un brulicare di vita. E amo i
suoi ritratti di vecchi, segnati dagli anni, ma
spogliati di ogni stanchezza esistenziale, volti
che restituiscono alla vecchiaia una dignità
dimenticata. Per me Occhipinti è il pittore
della leggerezza”.
Anche il compianto
giornalista Gino Alabiso scriveva: “Antonio
Occhipinti, apprezzato pittore di Gela, è
diventato l’allievo prediletto del pittore
Pietro Annigoni, il quale poco tempo fa posò per
un suo ritratto. Occhipinti lo ritrasse
mirabilmente e il “pittore delle regine” ne
rimase entusiasta al punto da donargli una sua
opera. Ogni commento è superfluo. Occhipinti,
che riscuote vivi successi nelle varie mostre a
cui partecipa (a Palermo, a Viareggio, a Pisa, a
Caltanissetta, a Cannes e in altri centri) è un
pittore veramente leale e non imbroglia le carte
(anzi le tele) in tavola. Fare un bel quadro è
difficile come fare una bella poesia, per chi ha
talento e coscienza. E Occhipinti raggiunge
quasi sempre nelle sue tele il livello della
poesia, in una malinconia di toni e prospettiva
che lasciano ammirati e pensierosi. Dei suoi
innumerevoli lavori (paesaggi, nature morte,
figure umane, marine ed altro) il nostro artista
segue lo stimolo di una eleganza intima,
adottando un linguaggio riflessivo, meditato e
spontaneo.
In chiusura in
ricordo del maestro Occhipinti si riporta quanto
scritto dal compianto Preside Prof. Virgilio
Argento: “Agosto 1982: Pietro Annigoni nel suo
studio-atelier di borgo Albizi, a Firenze, posa
per tre giorni per essere ritratto dal pennello
di un pittore venuto dalla provincia, che a lui,
come maestro, si è presentato con l’umiltà del
discepolo e l’ammirazione trepida
dell’ammiratore: Antonio Occhipinti. Posa
pazientemente, il maestro, dinanzi al pittore
gelese, così come avevano posato dinanzi a lui,
in anni che ormai si fanno lontani, i grandi
personaggi della storia, regine e capi si stato:
Elisabetta d’Inghilterra, Farah Tiba, Kennedy,
Johnson, Reza Palevi, Giovanni XXIII. Posa egli,
e nella sua inattività di soggetto che viene
ritratto, osserva e giudica quel pittore che
venuto da lontano, mentre questi osserva la sua
effigie sul bianco cartoncino del suo telaietto:
è l’osservatore e il giudizio del grande
artista, ormai al culmine della sua
straordinaria carriera. Il pittore gelese sente
il peso dello sguardo - che segue la sua mano -
dell’eccezionale soggetto, ma è incoraggiato nel
suo lavoro dallo squisito senso di umanità che
gli illumina il volto e che a lui si apre
generosamente: quel senso di umanità che è
proprio dei grandi artisti, che la burbanza,
l’alterigia è dei mediocri. E Annigoni è un
grande spirito. Quando Occhipinti termina la sua
fatica e gli offre in rispettoso omaggio il
quadro che ne è nato, allora egli esprime su
tale quadro il suo giudizio: una felice sintesi
“di trasparenze atmosferiche, vibranti di luce,
e di una corposità difficilmente ottenibile
nella tecnica usata dell’acquerello. E’ un
giudizio che è espressione della cortesia
dell’uomo, ma anche - e soprattutto -
dell’apprezzamento dell’artista. Evidentemente
nel realismo che impronta quelle linee e quei
colori, nella naturalezza della figurazione che
rende limpidamente, insieme ai suoi tratti
fisionomici, la verità sua interiore, egli vede
una consonanza con quello che è stato sempre il
suo credo artistico: “La pittura devota al
vero”, al manzoniano “vero” in arte, oltre che
nella vita.”.
IL BUSTO
MARMOREO DI RE UMBERTO I NELLA PIAZZA OMONIMA

La cartolina, del
1904, ritrae al centro della piazza il busto
marmoreo del re Umberto I costituito da un
piedistallo, corretto ed armonico nelle sue
linee architettoniche, in marmo di Carrara su
zoccolatura bugnata in breccia di Billiemi,
poggiante su un robusto basamento di forma
quadrata con scalini e pilastri angolari
provvisti di scuri è circondato da un
giardinetto con una ringhiera in ferro battuto.
Sul piedistallo si
eleva il mezzo busto del sovrano, realizzato da
Antonio Ugo, scultore palermitano di importanti
opere tra le quali primeggia la scultura del
cardinale Celesia nella
Galleria
d`Arte Moderna di Roma; su dei riquadri delle
quattro facce dello stesso piedistallo sono
riportate le città dove avvennero gli episodi
più importanti della vita del re: Busca,
Casamicciola, Napoli e Villafranca; inoltre, al
di sopra di quest’ultima città, in un altro
riquadro si legge “A Umberto I, I Terranovesi
1902”; tale anno si riferisce al compimento del
monumento al re, e non quindi alla sua
inaugurazione che avvenne il 20 settembre del
1903.
Sulla cartolina,
all’angolo della ringhiera del busto del re,
sono ritratti due ragazzi e sullo sfondo si
osserva il Palazzo Rosso con un fregio
settecentesco sul balcone del secondo piano,
mentre a pianoterra si vede l’insegna con la
scritta “SALONE”. Sul lato opposto, oltre alla
presenza di un artistico lampione a petrolio con
quattro punti luce, si osserva il palazzo
all’angolo via Matrice-via Porta Caltagirone
(quest’ultima poi nel 1911 denominata via
Giacomo Navarra Bresmes) con un numero di
aperture inferiori, dal pianoterra fino al terzo
piano (escluso il primo), rispetto a quelle di
oggi.

La Cartolina formato
14X9 cm. di colore vintage beige, porta
sullo spazio
inferiore del fronte delle scritte a penna
quali, “La piazza centrale”, la data del 27 - 9
-1904 e la firma “Bianca”; ed ancora con le
didascalie “Terranova di Sicilia”, “Monumento a
S.M. Umberto I” e sul margine inferiore “Fotog.
ed Edizione F.lli Lauricella, Terranova”. Sul
retro si leggono il numero della cartolina
“10248” e le scritte a stampatello al centro
“CARTOLINA POSTALE ITALIA (CARTE POSTALE
D’ITALIE)” e “N.B. Sul lato anteriore della
presente si scrive soltanto l’indirizzo” sul
margine sinistro; il francobollo vidimato è
quello del Regno d’Italia di 2 centesimi rosso
bruno (altezza mm. 23 e largo mm. 19) della
serie detta Floreale con la legenda: “Poste
italiane - cent. 2” e un sottile ornamento a
guisa di tronco inquadra il francobollo, ove,
dentro porta una corona di lauro e l'aquila
araldica di Savoia che reca lo scudo con la
Croce Sabauda. L’emissione del francobollo
avvenne con R. Decreto 6 giugno 1901, n. 255.
.jpg)
Nel 1952 il busto
marmoreo del re, nonostante che avesse dato la
denominazione alla piazza, fu espiantato per
essere trasferito all’interno della Villa
comunale. L’anno dopo al suo posto fu impiantata
inopinatamente una donna nuda bronzea, peraltro
definita arbitrariamente “Cerere” e quindi al
fuori da qualsiasi contesto storico cittadino,
d’altro canto era stata commissionata
all’artista Silvestre Cuffaro di Bagheria dalla
Regione Siciliana per destinarla chissà dove.
LA DISASTRATA FERROVIA DI GELA
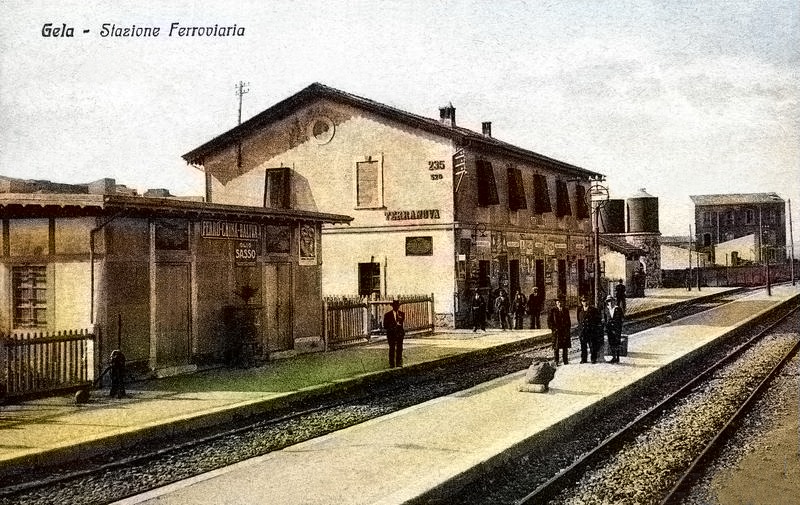
La rete ferroviaria
in Sicilia con i suoi 1400 Km. fino a qualche
lustro fa, prima di diversi incrementi,
rappresentava il 9% di quella nazionale. La
costruzione e l’esercizio delle prime linee
ferrate nell’Isola risale al 1861 quando il
Regno, facendo propria una proposta di Garibaldi
del 1860, decise con decreto reale del 1863 di
varare un piano per realizzare un sistema
ferroviario da dare in concessione a società
private. Le prime linee previste furono quelle
di Messina-Catania-Siracusa e
Palermo-Roccapalumba-Catania. Negli anni
successivi seguirono le linee Siracusa-Licata e
Canicattì-Licata, quest’ultima (come tratto
terminale della linea proveniente da Catania via
Caltanissetta) fu completata in due momenti: il
primo tratto Canicattì-Favarotta fu inaugurato
il 23 maggio del 1880 mentre il secondo
Favarotta-Licata fu inaugurato il 24 febbraio
dell’anno successivo.
Più laboriosa
risultò la realizzazione della linea
Siracusa-Licata in quanto il suo sviluppo in una
prima stesura, quella dell’Ing. G. Arnaldi, non
prevedeva di passare per Noto e per altre
principali città del Ragusano; infatti, il
Ministero dei Lavori Pubblici, per le numerose
lamentele, si vide costretto nel 1864 a dare
l’incarico all’Ing. Enrico Guerra affinché
ideasse un nuovo tragitto che, se pur più lungo
e più costoso, comprendesse pure le città di
Noto, Modica, Ragusa, Comiso e Vittoria prima
escluse.
Il progetto Guerra,
che prevedeva una linea lunga 177 Km. con 16
stazioni, fu approvato nel 1866 con una spesa di
previsione di trenta milioni di lire da ricavare
per 1/3 in azioni e 2/3 in obbligazioni.
Dall’approvazione
del progetto nel 1866 della linea
Siracusa-Licata fino alla sua completa
realizzazione del 1893, passarono ben ventisette
anni. Il primo tratto Siracusa-Noto fu
inaugurato il 5 aprile 1886; il tratto
intermedio Terranova (Gela)-Licata di 37 Km., fu
inaugurato il 28 marzo del 1891.
Nella nostra città e a
Licata quel giorno fu grande festa. Qui,
all'entrata di Porta Caltagirone, fu allestito
una specie di arco di trionfo con fiori, palme e
luminarie per accogliere con tutti gli onori
personaggi importanti, quali il principe Pietro
di Scalea, presidente della Società Ferroviaria
Sicula, il Prefetto, il concittadino Giuseppe Di
Menza, presidente della Corte di Appello di
Palermo, il comm. D'Anna, i sindaci di tutto il
circondario, deputati e senatori del collegio e
notabili.
A ricordo di
quell'avvenimento furono anche stampati opuscoli
riportanti poesie dedicate al “fumante ordegno”;
una di esse
del conterraneo Luigi
Vitali recitava: “Di
vita apportator, fumante ordegno / Ove corri
fulmineo al par dei venti? / Ove dirizzi il vol,
senza ritegno, / Cigolando con macchine
possenti? / Lo veggo: a te ne vien, che ne sei
degno, / Popolo industre: il plauso di tue
genti, / Che qui risuona, d’esultanza è segno: /
Inneggia lieto ai sospirati eventi. / Né viene
ei solo: vivido di luce, / Messaggero di fervidi
desiri, / Lo guida un genio: in mistico tributo,
/ Ei d’amistanza caldi sensi adduce, / E auspici
e voti candidi e sospiri… / E di Licata il
genial saluto!”. I
tempi di percorrenza del “fumante ordegno
…fulmineo al par dei venti” alla fine
dell’Ottocento tra Gela e Licata erano in media
di un’ora e un quarto con una velocità di circa
30 Km. orari.
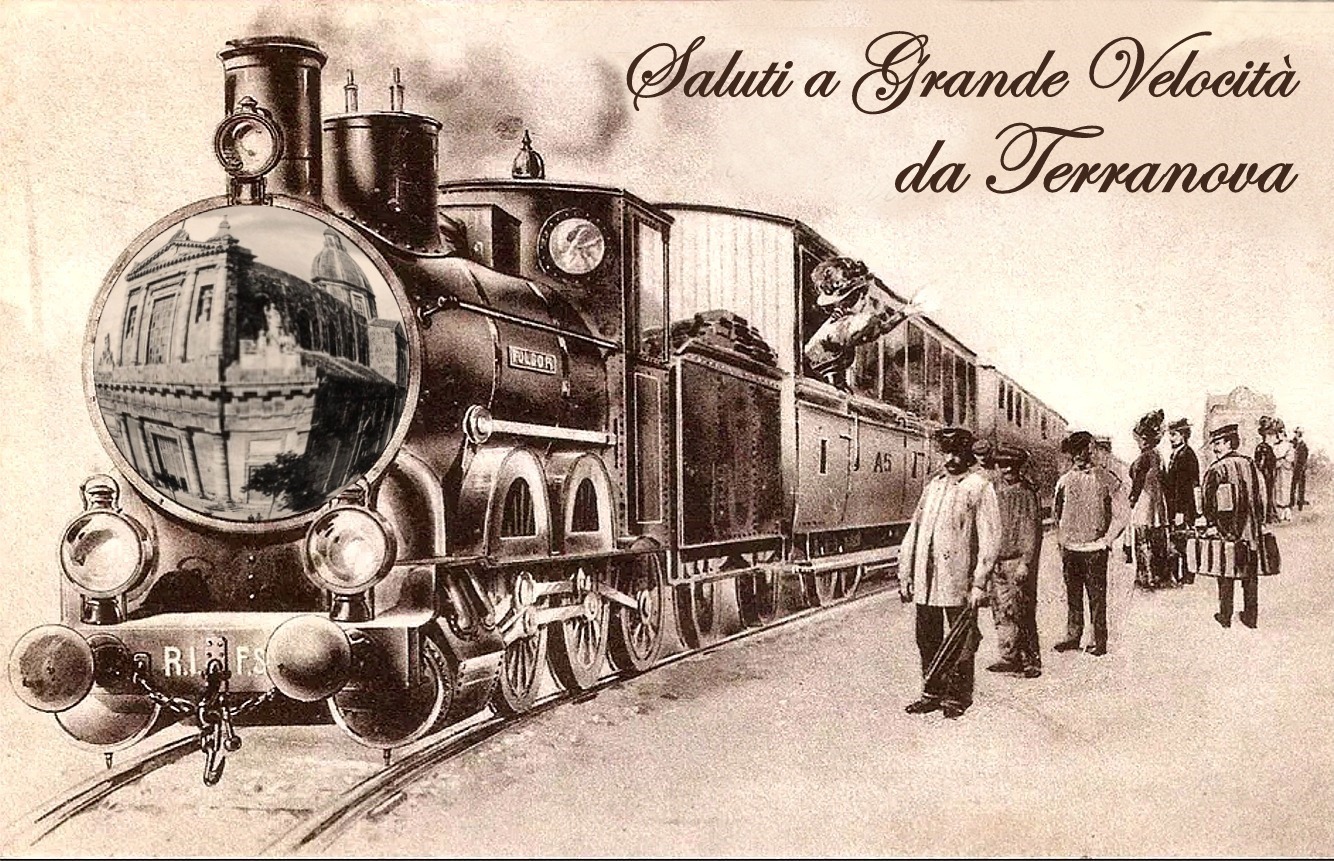
Il ricordo
gioioso di quella festa, però, durò per breve
tempo. Infatti, già dopo pochi anni dall'entrata
in esercizio di tale tronco ferroviario nacquero
lamentele e critiche feroci, di cui diamo un
brevissimo resoconto: “...Gli orari, lo scarso
numero di treni, la limitata potenzialità delle
locomotive, la deficienza di macchine e di
carri, la mancanza di piani scaricatori e di
binari destinati alla manovra dei carri, fanno a
gara per inceppare e danneggiare le sorti del
nostro traffico”. “...Lo stato delle vetture o
meglio carcasse destinate alla nostra regione è
semplicemente indecente: sono esse lo scarto di
vagoni già consumati che si mandarono quaggiù,
per noi barbari, e che specialmente nella linea
Caltanissetta-Terranova sembrano altrettante
latrine”. Viene spontaneo chiedersi: cos'è
cambiato oggi rispetto ad allora? Quasi niente,
anche se si è costruita una nuova stazione più
grande con diversi binari, sotto-passaggi ed
altre strutture, ma per chi e per che cosa
quando domani forse non passeranno più treni.
La linea
Siracusa-Licata fu messa in esercizio il 18
giugno del 1893 con l’inaugurazione della tratta
Comiso-Modica.
Nella seconda metà
degli anni Settanta (24 luglio 1977) lo scalo
ferroviario di Gela, ubicato nel centro storico,
fu trasferito nella sede attuale a nord di via
Venezia, a ridosso del Villaggio Aldisio.
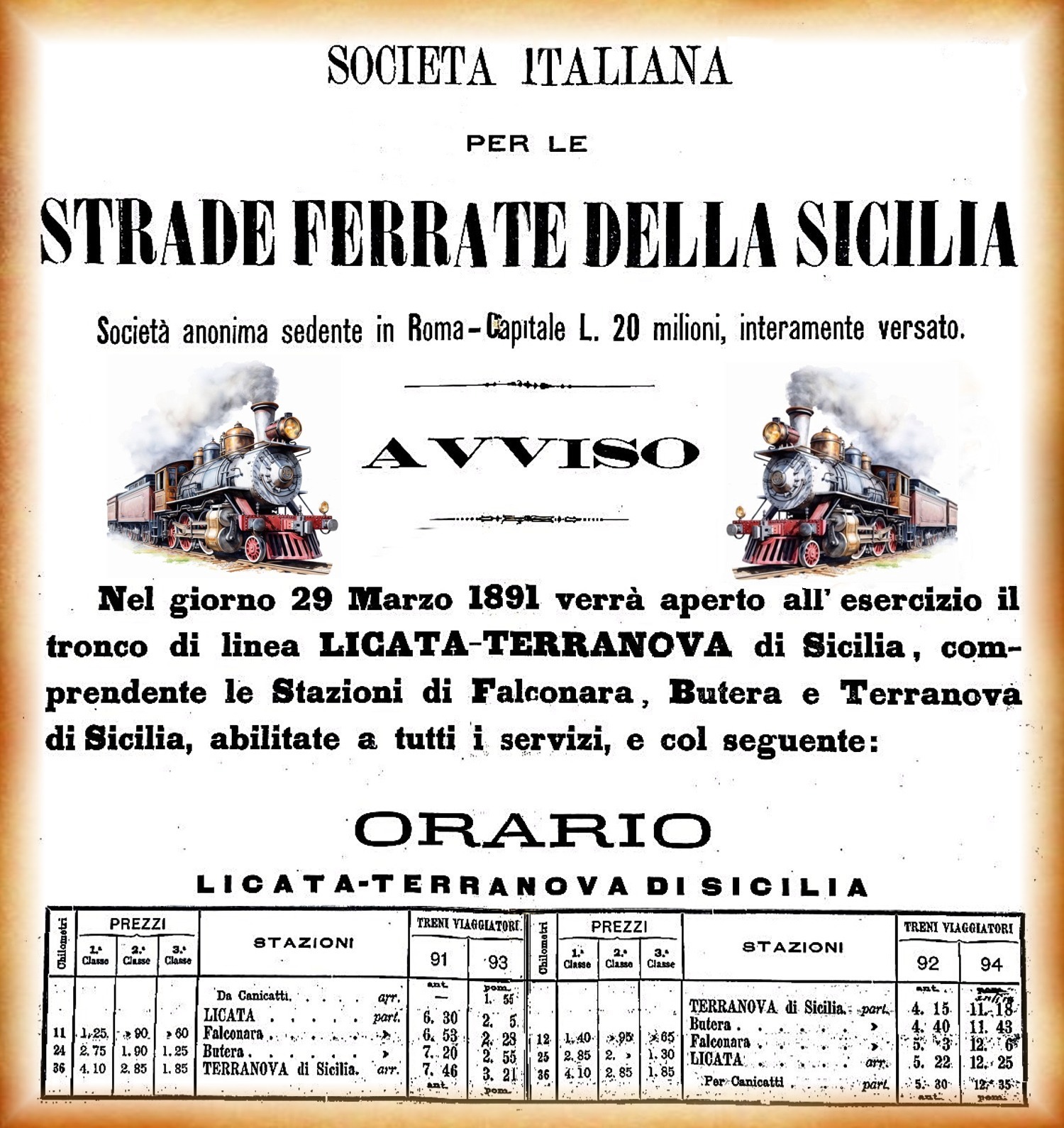
Dopo ben ottantasei
anni dall’entrata in esercizio della ferrovia
Siracusa-Licata, da Gela è stata attivata, il 29
novembre del 1979, la tratta
Gela-Niscemi-Caltagirone-Catania di 137 Km., il
cui primo tracciato Gela-Caltagirone fu iniziato
nel 1928;
Il progetto per la
ferrovia Caltagirone-Niscemi-Terranova risale al
1895; fu realizzato dall'Ing. Arch. Cavallari
Salvatore, su uno studio di massima realizzato
prima, nel 1883, dal direttore generale delle
Ferrovie Sicule, Comm. Ing. Adolfo Billia.
Nel 2009 era prevista l´attivazione della linea
veloce ed elettrificata, sui 183 Km a binario
semplice, della tratta Siracusa-Ragusa-Gela che
oggi si compie in tre ore e mezza con una
littorina (locomotive diesel D 343 e D443) con
punte di velocità massima di 100 Km. orari. E
per l’elettrificazione di tale linea? Stiamo
ancora aspettando!
Ogni commento su
questa nostra disastrata ferrovia è superfluo.
Ne facciamo a meno, anche perché la tratta
Gela-Catania da decenni è interrotta, tant’è che
qualche anno fa i tombaroli del ferro stavano
iniziando a trafugarne i binari. E comunque se
ancora esiste l’attuale tratta ferroviaria di
Gela forse trattasi di un “miracolo” o forse una
dimenticanza, nonostante i tagli dei cosiddetti
rami secchi a cui hanno sottoposto la linea
ferrata siciliana.
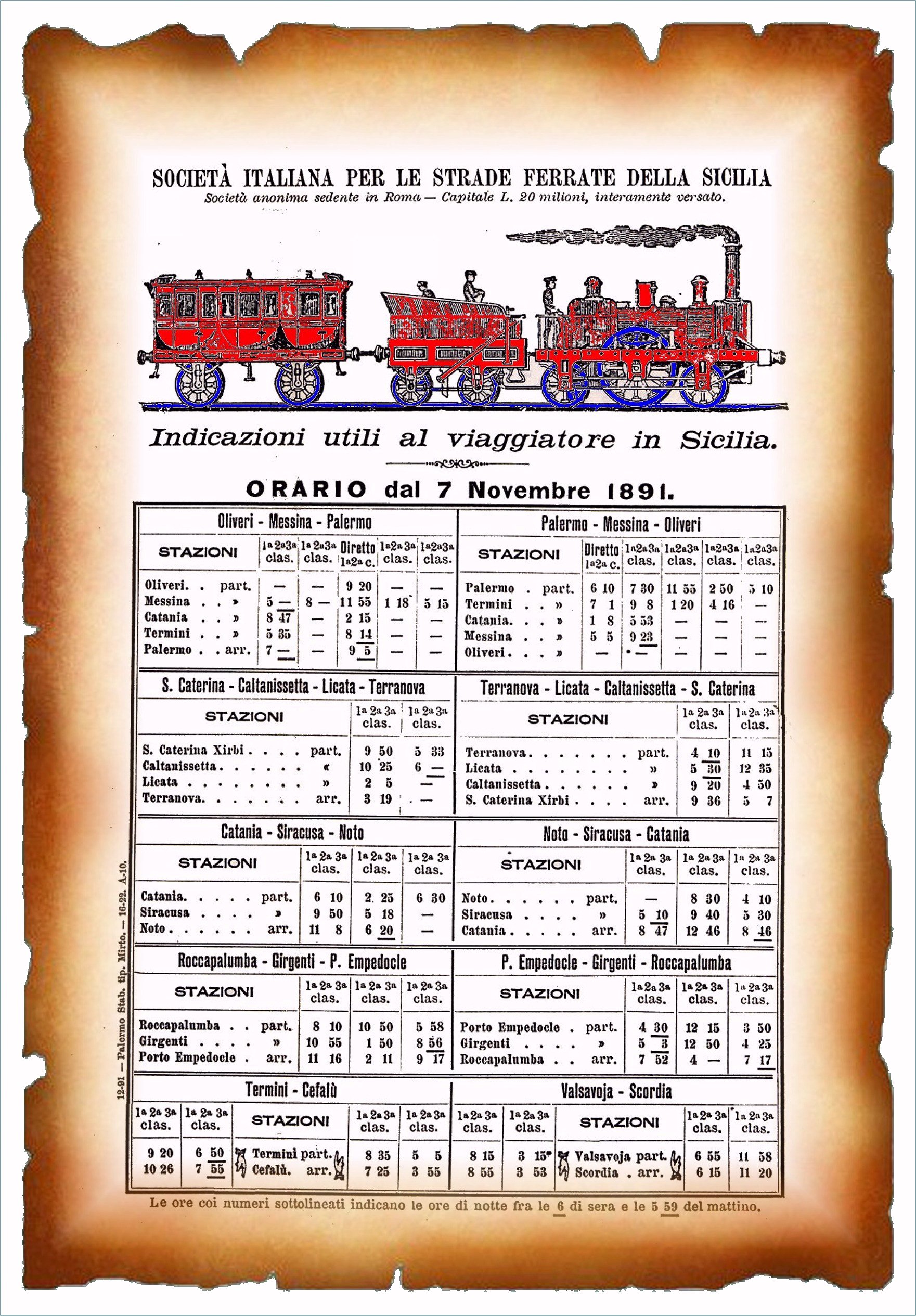
E’ bene, però,
riflettere un po’ su come si e arrivati a
rendere improduttiva questa linea ferrata, che
per decenni ha costituito un'importante linea di
comunicazione tra decine di comuni di ben cinque
province. Quando a partire dagli anni Sessanta,
in coincidenza con la nascita del petrolchimico
gelese, venivano realizzate importanti
infrastrutture e mentre la tecnologia portava
continue innovazioni nel campo degli
autoveicoli, sulla linea in oggetto, le FF.SS.
cosa fecero? Niente! Lasciarono la littorina,
con un binario unico e con i tempi di
percorrenza simili a quelli esistenti nelle
ferrovie di primo Ottocento. Chi più chi meno,
molte persone nei decenni passati si sono
trovati nella necessità di percorrere la linea
Catania-Gela via Siracusa, con un minimo di sei
ore di viaggio.
Prima che la linea
Gela-Catania si fosse interrotta, la tratta si
percorreva in quasi tre ore, anche se tali ore
potevano essere dimezzate, eliminando (sic et
simpliciter) alcune fermate intermedie inutili;
non abbiamo mai saputo quali siano stati i
motivi che rendevano impossibile questa
operazione, ma siamo sicuri che molta gente
sarebbe stata invogliata ad usare di più il
treno per viaggiare.
In conclusione, ci
sembra di capire che nella nuova gestione
aziendale delle FF.SS. prevalga ancora una volta
la logica di far pagare pesantemente al Sud, e
solo al Sud, il fio degli errori di una classe
politica fellona, in continuazione di una
famigerata tradizione “piemontese”, che dura dai
tempi dell’Unità d’Italia.
Intanto nei primi
giorni del mese di dicembre del 2024 la stazione
ferroviaria di Gela è tornata ad essere
operativa dopo oltre nove mesi di fermo per la
ristrutturazione di traversine e binari.
Inoltre, le littorine sono state sostituite con
i più moderni treni ibridi Minuetto e Blues.
Diversa invece è la situazione della stazione di
Gela e relativi spazi che ancora si trovano in
uno stato di abbandono.
Nel 2022, grazie ad
un finanziamento di circa 150 milioni di euro
dei fondi PNRR, è iniziata la progettazione del
ripristino della linea ferrata Gela-Caltagirone
(inaugurata il 29 novembre 1979 e interrottasi
nel 2011 dopo il cedimento strutturale del ponte
in c.da “Discesa del Angeli” verso Niscemi) da
realizzare in due lotti per un costo di circa
150milioni di euro; il secondo lotto, di circa
25 Km., riguarda la linea ferrata Niscemi-Gela.
Il ripristino della
tratta Gela-Catania via Caltagirone a modo di
vedere dello scrivente, non ha più motivo di
esistere almeno per Gela date le numerose corse
degli autobus di linea esistenti oggi e i cui
fruitori spesso le utilizzano solamente per
arrivare all’aeroporto di Catania.